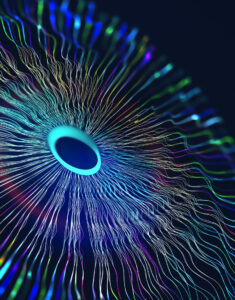Italia, non bastano le vittorie
 Negli ultimi mesi c’è stata una serie di notizie positive sull’Italia, sia da un punto di vista economico, sia per quanto riguarda una serie di eventi che hanno visto il nostro Paese primeggiare in diversi ambiti. Secondo molti, questi avvenimenti hanno anche un valore economico e di traino dell’economia del Paese. Be Private ne ha parlato con Giorgio Arfaras, del Comitato scientifico del Centro Studi Einaudi.
Negli ultimi mesi c’è stata una serie di notizie positive sull’Italia, sia da un punto di vista economico, sia per quanto riguarda una serie di eventi che hanno visto il nostro Paese primeggiare in diversi ambiti. Secondo molti, questi avvenimenti hanno anche un valore economico e di traino dell’economia del Paese. Be Private ne ha parlato con Giorgio Arfaras, del Comitato scientifico del Centro Studi Einaudi.
Sta davvero cambiando qualcosa in Italia?
«Bisogna distinguere i diversi piani: l’immaginario, il mediatico e l’andamento effettivo dell’economia. Il primo è quello che ci fa gioire per avere vinto l’Eurovision song contest, passando per i campionati europei, le Olimpiadi, sino ad arrivare al premio Nobel, portandoci a dire che l’Italia ha un grande avvenire. È un messaggio che viene veicolato a livello mediatico, pubblico e privato. Poi c’è appunto il mondo mediatico, che guarda al +6% di crescita del Pil per quest’anno e al 4% per il prossimo, riferendosi solo ai valori assoluti, senza tenere conto che, per quanto le cifre siano consistenti, dopo due anni si arriverà a un livello poco superiore a quello dell’attività economica pre-pandemia. In altre parole, ci si dimentica di guardare i risultati in modo aggregato, evitando di computare anche il crollo del 2020. Ciò vuole dire che, analizzando la situazione nel suo insieme, si è di fronte a un rimbalzo congiunturale, ma senza caratteristiche strutturali. Disaggregando i numeri, si rileva che c’è stata una ripresa dei consumi, dell’attività industriale e delle esportazioni, dovuta all’interruzione precedente, che si è manifestata con dinamiche simili all’interno dei tre segmenti. Ciononostante, i numeri del Pil sono stati sufficienti perché iniziasse una campagna che sottolineava che l’Italia si era rimessa in carreggiata, corroborata ulteriormente dall’arrivo dei soldi europei. Questi ultimi sono senza dubbio una novità e basterebbe guardare a quanto avvenuto nelle crisi precedenti del 2009 e 2011. Allora fu solo la politica monetaria che rispose con misure straordinarie espansive, mentre quella fiscale rimase improntata all’austerità. Furono gli anni del “whatever it takes” di Mario Draghi. Nella situazione attuale ci troviamo sempre dinanzi a un “whatever it takes” quasi perpetuo, accompagnato però questa volta da politiche fiscali espansive che si esplicitano nel Recovery fund, la vera novità europea, ovvero un’emissione di debito in solido. Poiché l’Italia, in cifre assolute e non in rapporto al Pil, è il Paese che beneficia dell’ammontare più consistente, in parte gratis e in parte a pagamento, ciò ha alimentato la convinzione che questi soldi possano cambiare il destino della nazione».
La cifra del Recovery fund è cospicua…
«Bisogna però chiedersi se l’impatto di questi soldi sarà dovuto al fatto che sono tanti o che sono spesi bene. In termini di volume, si parla di circa 200 miliardi di euro in più anni. Supponiamo che questi capitali vengano erogati nell’arco di un decennio in modo omogeneo, ovvero 20 miliardi ogni anno. Gli investimenti lordi delle imprese italiane ammontano a circa 200 miliardi di euro all’anno, pari al livello dei loro ammortamenti. Si deduce che i finanziamenti del Recovery risulterebbero uguali, per ogni anno, a un decimo degli ammortamenti. Nel sistema mediatico e nell’immaginario collettivo è però la cifra dei 200 miliardi che impressiona, anche se, tengo ancora a sottolineare, non è una questione di volume, ma di qualità degli investimenti. A ciò va aggiunta una riflessione. L’esperienza passata ci insegna che l’Italia è sempre riuscita a spendere il 50% dei finanziamenti ricevuti dall’Europa. Nel misurare l’impatto del Recovery, dovremmo quindi fare l’assunzione che ciò non avvenga e tutti i soldi vengano spesi senza dispersione. Badi bene che questa è un’assunzione forte, in cui non rientrano i calcoli di probabilità. Supponendo che non ci siano intoppi, si tratterebbe di implementare un piano, il Piano nazionale di resilienza e ripresa (Pnrr), che ha obiettivi ecologici e redistributivi, sia in termini di gender, sia di differenze reddituali, cui va aggiunta una forte spinta tecnologica per la digitalizzazione delle reti e delle infrastrutture. Questo è, in estrema sintesi, il progetto declinato nel Pnrr. C’è però un vincolo ed è il deficit pubblico».
Di quale tipo di vincolo si tratta?
«Se si guarda il bilancio dello stato, si evince che il deficit, per quanto in riduzione, è cospicuo. Esso non è finanziato con moneta, ma con l’emissione di obbligazioni, acquistate al 50% dalla Banca Centrale Europea attraverso la Banca d’Italia e per il 30%, del restante 50%, da investitori privati esteri (i dati sono riportati dalla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza-Nadef del 2020). Ciò significa che circa 2/3 degli acquisti di debito italiano sono nelle mani di chi ha la discrezionalità di giudicare l’operato del Paese e le cui decisioni in merito sono vincolate alla valutazione dello stesso. Posto che si riesca fare tutto ciò che il piano si prefigge, nonostante le difficoltà rimangano, ci sono altri due problemi strutturali dell’Italia che non sono mai menzionati, né a livello d’immaginario, né mediatico e neppure quando si parla di problemi concreti. Si tratta di due aspetti squisitamente microeconomici: il nanismo delle imprese italiane e il Meridione».
Due problemi microeconomici, ma strutturali dell’Italia.
«Il primo è il cospicuo numero delle aziende italiane sino a 10 dipendenti, il doppio di quelle francesi e tedesche. Più le imprese sono di dimensioni ridotte, minore è la loro economia di scala. Esse producono un valore aggiunto inferiore e hanno livelli di retribuzione più bassi, con conseguenti versamenti Irpef e Inps più contenuti. Se ne deduce che il meccanismo delle nano-imprese rischia di essere perverso, perché, se “piccolo è bello”, l’effetto sui conti pubblici e sulla comunità non lo è altrettanto. Con ciò non voglio dire che il problema non verrà affrontato, ad esempio con progetti per incentivare le società a fondersi, ma di fatto è un argomento di cui non si parla. Il secondo tema, del quale, anche in questo caso, non viene fatto alcun cenno, è il Meridione. Nella regione, come è noto, si è puntato a sviluppare le infrastrutture, poi a trasferire alcuni centri produttivi con interventi pubblici, senza raggiungere però risultati positivi, vista la mancanza della certezza del diritto. È stata quindi portata avanti una serie di tentativi che hanno sì migliorato le condizioni del Meridione, perché in termini di attese di vita e di livello di istruzione è uguale al Nord d’Italia, ma rimane un problema: il reddito pro capite siciliano, che a sua volta dipende dai trasferimenti della Lombardia verso la Sicilia, è la metà di quello lombardo».
Ma se, metaforicamente, dovessimo mettere l’Italia sulla linea di partenza dei centro metri della politica e dell’economia, come apparirebbero le sue condizioni?
«Il rimbalzo dell’attività economica riporterà il Paese a livelli pre-crisi e gli investimenti dovranno essere ben fatti e, in fondo, non sono così consistenti. Quindi, l’Italia si presenta sì sulla linea di partenza dei 100 metri, ma con problemi che non sono affrontati nello sforzo di costruire un Paese virtuoso. Non ho soluzioni su come risolvere la questione del nanismo di impresa e del Meridione: le potenzialità ci sono e gli imprenditori italiani hanno dimostrato di avere grandi capacità. Si tratta solo di approcciare le questioni in modo sistematico e cominciare a discuterne nel concreto. L’altro interrogativo che mi pongo, più in generale, è se ci illudiamo che le cose debbano arrivare senza sforzo o è meglio parlare dello sforzo. Il problema è squisitamente politico, perché, per affrontare le situazioni per ciò che veramente sono, occorrono molto coraggio, determinazione e non avere secondi fini da perseguire. La vera domanda è quale sia la coalizione di forze che può portare l’Italia nella direzione che è necessario intraprendere per affrontare i problemi di fondo, ma ciò dipenderà se prevarranno le forze della riforma piuttosto che quelle della conservazione attraverso la distribuzione della spesa».
In Italia ci sono però esempi di eccellenza tra le piccole e medie imprese.
«Ci sono piccole e medie imprese fortissime, soprattutto se occupano nicchie di mercato e sono solide patrimonialmente. Se c’è una crisi finanziaria, una società di grandi dimensioni può affrontarla senza avere gravi contraccolpi, continuando ad accedere ai canali di finanziamento e a investire in ricerca e sviluppo. Una nano-impresa, se iper-indebitata, nella stessa situazione rischia di saltare o comunque subisce un ridimensionamento del reddito tale da bloccare qualsiasi forma di investimento. In media, la fragilità della Pmi è legata alla leva finanziaria e alla mancanza di mezzi per fare ricerca e sviluppo. Va però ricordato che questo non è un problema dell’economia industriale italiana, ma è comune a tutti i paesi. Se si guarda, infatti, ai dati dell’Ocse, emerge che più le imprese italiane diventano grandi, più aumenta la loro capacità competitiva e dai 250 dipendenti in su la loro produttività è superiore a quella delle omologhe francesi o tedesche. Pertanto nel Dna degli italiani il sapere fare impresa è ben presente, ma occorre che ci siano le economie di scala. E poi c’è un fatto storico cui si può ricondurre il nanismo e riguarda la diffusione delle imprese italiane, che da un certo momento in poi cominciarono a nascere e proliferare là dove c’era la mezzadria. Il mezzadro era un piccolo capitalista, a differenza del salariato agricolo, che cominciò ad aprire un’attività industriale che poi venne sviluppata dal figlio e continuata dal nipote. Ma ovviamente non tutte le attività erano floride, generavano valore e meritavano di continuare a esistere».
E per quanto riguarda le grandi imprese italiane?
«Le grandi aziende private italiane famose erano la Fiat, la Montedison, la Olivetti e la Pirelli. Di questa grande tradizione è rimasta solo la Fiat, che ha spostato la sua sede all’estero. Diciamo, generalmente parlando, che anche in questo caso ci si trova di fronte a realtà industriali che non hanno avuto la capacità di continuare a essere grandi. In Italia abbiamo un tessuto manifatturiero dove non ci sono le grandi imprese e neppure un sistema relativamente ridotto di nano-imprese, con tante medie aziende molto forti».
Vede un cambiamento di passo in Europa in termini di politiche fiscali?
«Penso che l’idea che meno male che l’Europa è cambiata e che non esistono più i vincoli di Maastricht, per cui si può fare deficit perpetuo perché la Banca Centrale continuerà a comprare obbligazioni all’infinito, sia una vulgata che trova spazio solo nel mondo della fantasia. L’Europa ha risposto con misure eccezionali a una situazione eccezionale. Anche i facili ottimismi all’indomani delle elezioni tedesche, di una Germania sempre più lontana dall’austerità, non hanno basi molto solide. Se nel Paese si dovesse infatti formare una coalizione di governo con la presenza del Partito liberale, non vedo grande spazio per politiche fiscali particolarmente espansive. Inoltre, non va dimenticato che la Cdu-Csu ha comunque il controllo delle regioni più ricche della Germania, il cui peso e influenza politica a livello nazionale non vanno ignorati».
Qual è il ruolo di Mario Draghi e dell’attuale governo?
«Il ruolo dell’attuale governo è, in termini generali, di fare in modo che non si torni alle vecchie abitudini di continuare a rimandare le cose, sperperare il denaro, evitare che acquistino spazio posizioni folkloristiche, come uscire dall’euro o abbandonare l’Alleanza atlantica, e che siano posticipate le riforme. Non è un compito facile, visto che il governo attuale è l’espressione dell’incapacità del sistema politico di riformarsi e ha bisogno di chiedere un aiuto esterno a un tecnico. Egli può essere visto quasi come un taxi, che i partiti utilizzano per coprire quel tratto di strada che per loro è difficile da percorrere. Il suo ruolo è svolgere quelle incombenze sgradevoli di cui la politica non vuole assumersi la responsabilità. Il tecnico diventa così il capro espiatorio, su cui si potranno eventualmente scaricare le colpe, in modo che la comunità torni a essere solidale. Draghi è un tecnico, ma con un respiro ben maggiore dei suoi predecessori, un portatore di consenso con una grande esperienza internazionale. Il suo compito è evitare il peggio, forzando l’Italia fuori dalle sue cattive abitudini storiche».
Intravede cambiamenti significativi in corso?
«Ci sono alcuni movimenti in campo politico che ci fanno pensare che sia viva l’opzione che è troppo pericoloso tornare indietro. Essi sono la riduzione della passione populista all’interno del Pd, il “giorgettismo” nella Lega, il “brunettismo” in Forza Italia, il sostanziale appoggio a tutto ciò che Mattarella e Draghi fanno. Ci sono questi segnali che vengono dal mondo della politica, poi, però, bisogna vedere come saranno effettuate le prime spese legate al Pnrr. Se queste fossero fatte in modo efficace ed efficiente, potrebbe svilupparsi un fenomeno a palla di neve che si gonfia e genera effetti positivi a catena».