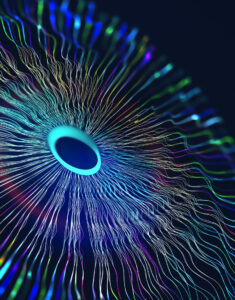Un’occasione cruciale, praticamente irripetibile
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ormai noto come Pnrr, è l’insieme di misure e investimenti proposti dal governo italiano alla Commissione europea e poi approvato dal nostro Parlamento per attuare gli obiettivi del pacchetto di misure che vanno sotto il nome di Next generation Eu, più conosciuto presso il pubblico come Recovery plan. In particolare il Pnrr si riferisce alla quota italiana di uno dei due componenti in cui si articola il Recovery, ossia il Dispositivo per la ripresa e la resilienza. All’Italia sono stati assegnati, solo all’interno di questa voce, 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 a fondo perduto, su un totale di 672,5. Si tratta di una cifra che dovrà essere impiegata nel prossimo quinquennio.
Il Pnrr si articola in sei componenti:
a) digitalizzazione, innovazione e competitività;
b) cultura e turismo;
c) rivoluzione verde, transizione ecologica e infrastrutture per una mobilità sostenibile;
d) istruzione e ricerca;
e) inclusione e coesione;
f) salute.
sedici obiettivi
In totale dovranno essere raggiunti 16 obiettivi determinati all’interno del piano. L’ammontare complessivo riservato al Belpaese rappresenta di gran lunga la porzione più ampia del totale continentale: in parte ciò è dovuto alle dimensioni notevoli dell’economia nostrana, in parte alla devastazione procurata al nostro Paese dal Coronavirus, che è andata a inserirsi in un quadro di progressiva fragilità dell’Italia.
Per comprendere, infatti, l’importanza e il ruolo che il Pnrr potrebbe avere per i destini nazionali, bisogna tornare indietro nel tempo. Nello specifico è necessario partire analizzando l’impatto della pandemia in Italia nel 2020 e come abbia messo a dura prova un’economia fragile, che viene da decenni di crisi strisciante. Una crisi che è diventata evidente, a essere generosi, già dalla fine degli anni ‘90. Innanzitutto, va detto che nel corso del 2020 il Pil nazionale ha visto una contrazione dell’8,9%, con un contemporaneo aumento del tasso di povertà relativa, che è passato dal 7,7% al 9,4% della popolazione. Altri paesi, però, hanno mostrato cifre ancora peggiori: tra le grandi economie Ocse ci sono Spagna e Regno Unito. Ma non va dimenticato che, fino all’avvio a pieno regime della campagna vaccinale lo scorso aprile, l’Italia mostrava il tasso di mortalità pro capite da Covid più alto dell’occidente dietro il Belgio, dopo un anno caratterizzato da alcuni dei lockdown più lunghi e duri adottati all’interno dell’Ue.
Sicuramente in generale l’Europa ha pagato un prezzo altissimo alla pandemia per ragioni strutturali, che esulano dal quadro della Penisola. Da una parte, infatti, il profilo demografico vede una percentuale decisamente elevata, rispetto al resto del mondo, di anziani, dall’altra una vasta area terrestre caratterizzata dalla libera circolazione degli abitanti non ha favorito una rapida messa in sicurezza delle frontiere come è avvenuto in Asia. Quest’ultima, per di più, almeno nelle sue economie avanzate, vanta sicuramente una maggiore pervasività delle tecnologie digitali, fondamentali nei processi di tracciamento, una minore pesantezza burocratica e garanzie in termini di privacy sicuramente inferiori rispetto agli standard Ue.
Un’Italia a corto di risorse
Il sistema Italia, però, ha mostrato diverse debolezze specifiche che vengono da lontano e che dovranno essere assolutamente risolte, se si vuole fare ripartire il Paese e mantenerlo nel gruppo delle economie più avanzate. Un solo dato serve a mettere a fuoco la situazione di grave crisi con cui si è arrivati alla prova Coronavirus: nel 2019 la spesa sanitaria totale per abitante, sia pubblica, sia privata, in Italia è stata 3.653 dollari. Per comprendere la gravità di questo numero, vale la pena operare un confronto: il totale italiano è solo di poco superiore rispetto ai 3.417 dollari della Repubblica Ceca e ai 3.406 della Corea del sud. Nel primo caso si tratta di una realtà caratterizzata da un Pil pro capite nominale e da una struttura dei costi significativamente inferiori rispetto a noi. La Corea del sud presenta, invece, numeri economici praticamente identici a quelli italiani, ma è un’economia non certo nota per la pervasività del proprio stato sociale, dove la quota di popolazione over 65 è pari a circa i due terzi dell’equivalente italiano, mentre gli over 80 (ossia i cittadini bisognosi di maggiori cure) sono circa la metà. Inoltre, un confronto con le maggiori economie europee mette a nudo la scarsità delle risorse impiegate in ambito sanitario. Il Regno Unito ha infatti speso nel 2019 in cura della salute 4.500 dollari a persona, la Francia 5.274 e la Germania addirittura 6.518.
Molta spesa corrente, pochissimi investimenti
Le cifre riportate vanno a inserirsi in un contesto che potrebbe apparire controintuitivo, se non addirittura insultante, alla maggior parte degli italiani, ossia il fatto che il nostro stato è a corto di risorse rispetto alla maggior parte delle economie avanzate. Anche in questo caso, un confronto con realtà a noi vicine aiuta: nel 2019, infatti, la spesa pubblica nazionale per persona è stata complessivamente meno di tre quarti rispetto a Francia e Germania. Inoltre, il nostro Paese si caratterizza per un elevato livello di spesa corrente, con una concentrazione significativamente elevata in ambito pensionistico. Infatti, la Penisola ha allocato sotto questa voce nel 2019 il 16,91% del Pil: al mondo solo in Grecia si trovano cifre più elevate. Fra le grandi economie europee la Francia (14,5%) si avvicina a noi; a seguire fra i grandi paesi europei compresi nell’Ocse troviamo la Spagna (11,89%), la Germania (9,9%) e il Regno Unito (6,53%). Contemporaneamente, lo stato italiano ha dovuto tagliare, oltre che su una serie di servizi essenziali, come appunto la sanità, anche nel fondamentale ambito degli investimenti.
In Italia, nel ventennio 1999-2019 si è investito infatti poco e, probabilmente, male: complessivamente l’ammontare degli investimenti in quel periodo è aumentato cumulativamente del 66% a fronte di una media dell’Ue di +118%. In particolare, è venuto a mancare in buona parte il contributo del pubblico: nel 1999, infatti, da questa fonte proveniva il 14,6% del totale investito, mentre nel 2019 si era scesi al 12,7%. Il risultato è stato un andamento del Pil anemico, a essere molto benevoli: sempre nel succitato ventennio, il prodotto interno lordo è salito complessivamente del 7,9%. Si tratta di un incremento che non si avvicina neppure lontanamente a quello messo a segno dalla Francia (+32,4%) e dalla Germania (+30,2%). Addirittura la produttività totale dei fattori è calata del 6,2%. In pratica, la nostra economia è entrata in una spirale negativa, dove la bassa crescita ha portato a una relativa scarsità di risorse statali per finanziare innovazione e sviluppo, elemento che ha ulteriormente peggiorato lo sviluppo del Pil.
Uno strumento di politica fiscale moderna
Visti i numeri (sconsolanti) esposti finora, dopo la pandemia l’Europa ha finalmente compreso che è necessario uno scatto espansivo nel continente, con al centro di questa azione proprio l’Italia e in particolare il Meridione. Non si deve infatti dimenticare che il 40% delle risorse del Pnrr sarà allocato proprio al Sud, che da due decenni a questa parte vive in maniera amplificata i problemi appena descritti. Ci troviamo di fronte dunque a un gigantesco impulso fiscale keynesiano, dopo un decennio di semi-austerità.
A questo punto, appare quasi ovvio aggiungere che per il nostro Paese è assolutamente fondamentale non sprecare la pioggia di soldi in arrivo. Come si può capire dagli obiettivi del Pnrr, la liquidità dovrà infatti essere indirizzata a un processo di riforme strutturali in grado di fare compiere all’Italia il salto definitivo verso il mondo moderno.
Fondamentale, peraltro, sarà il ruolo degli intermediari finanziari. Infatti, da una parte si spera che stato e imprese siano in grado di avviare un dialogo positivo, capace di portare all’implementazione dei migliori standard tecnologici e produttivi, fatto che non si è sempre verificato in passato nella gestione degli appalti pubblici. Dall’altra è necessario che istituti di credito e investitori offrano soldi a sufficienza, e in forme innovative, per fare fronte alle necessità di capex e gestione della liquidità corrente.
In questo senso non mancano, però, segnali incoraggianti: basti pensare, ad esempio, alla forte crescita registrata in Italia negli ultimi anni dagli strumenti finanziari incentrati sugli asset privati. Interessanti e indicative al riguardo appaiono le conclusioni di Vincenzo Butticé, assistant professor al Politecnico di Milano (Dipartimento di management, economia e ingegneria gestionale), che ha condotto per l’Aipb una ricerca sul contributo del settore del private banking alla crescita degli investimenti in Pmi: «Il quaderno di ricerca del Politecnico di Milano indaga la dimensione quantitativa e qualitativa del risparmio gestito dal private banking nel finanziamento delle Pmi italiane attraverso i fondi di investimento alternativi (Fia), ponendo l’attenzione sulle imprese non finanziarie. I risultati di ricerca mostrano che, soprattutto in anni recenti, il risparmio gestito dal private banking ha finanziato operazioni di aumento di capitale e debito privato attraverso la selezione di Fia con impatti molto significativi sulla crescita delle imprese. Lo studio evidenzia la capacità degli operatori private di individuare i fondi con più alto potenziale di crescita e il valore dell’industria private, quale leva strategica per permettere in futuro alle piccole e medie imprese di raggiungere gli obiettivi di patrimonializzazione e di sviluppo».
Un aspetto, infatti, da non dimenticare è che il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr è legato indissolubilmente al coinvolgimento, alla crescita e alla modernizzazione dell’immenso sistema nazionale delle Pmi. Queste ultime si trovano da sempre e, in particolare negli ultimi 10 anni, con acute necessità di capitali; è perciò sempre più indispensabile un più solido canale di connessione fra la liquidità dei risparmiatori e le nostre aziende, anche perché, se il Pnrr desse i suoi frutti, si dovrebbe avviare in Italia un programma di ammodernamento e investimenti pluridecennale. Basti pensare al fatto che il solo processo di transizione verso un modello economico sostenibile implica necessità di investimento per 3 mila miliardi di euro da qui al 2050!
Per fare sì che i fondi europei rappresentino la miccia in grado di fare esplodere un circolo virtuoso fra stato, protagonisti del sistema finanziario e il complesso delle imprese, è indispensabile un ulteriore sforzo di innovazione a tutti i livelli, come sottolinea ancora Vincenzo Butticé: «Occorrerà, però, da una parte, che il mercato e i gestori riconoscano le peculiarità del “target market” di investitori individuali serviti dal private banking, facilitando il loro accesso a prodotti e strategie specializzati in economia reale italiana. Dall’altra, naturalmente, sarà necessario dare continuità alle politiche economiche e fiscali volte ad agevolare gli investimenti in questi strumenti assicurando al mercato finanziario e agli investitori, sia nazionali, sia internazionali, un respiro almeno decennale alle iniziative messe in atto dalle istituzioni. Sarà anzi fondamentale rimuovere gli ultimi ostacoli che permangono in termini di interpretazione delle normative fiscali nazionali e di coerenza regolamentare tra le diverse direttive europee dedicate alla tutela degli investitori, per creare un ecosistema stabile e favorevole a sostegno degli investimenti dell’economia reale».
Se ciò non si dovesse verificare, con ogni probabilità l’Italia darebbe addio al gruppo delle economie rilevanti sul pianeta.