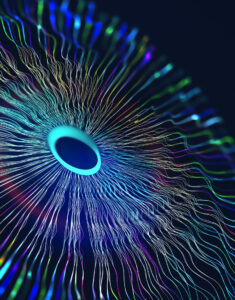Gestire al meglio un liquidity event
 Quando si parla di protezione degli asset e di continuità generazionale, non si può prescindere dall’analizzare come si evolve la situazione patrimoniale di una famiglia in presenza di un evento di liquidità. È un momento importante e delicato da gestire, soprattutto per un’azienda, che richiede una strutturazione attenta dell’operazione in sé e una pianificazione per la gestione futura dello stesso patrimonio. A spiegarlo è Gianluca Rondini di Credem private banking.
Quando si parla di protezione degli asset e di continuità generazionale, non si può prescindere dall’analizzare come si evolve la situazione patrimoniale di una famiglia in presenza di un evento di liquidità. È un momento importante e delicato da gestire, soprattutto per un’azienda, che richiede una strutturazione attenta dell’operazione in sé e una pianificazione per la gestione futura dello stesso patrimonio. A spiegarlo è Gianluca Rondini di Credem private banking.
Che cosa è un “liquidity event” e qual è il ruolo ricoperto dal private banker?
«Si tratta di un evento che si genera quando l’imprenditore o i soci di un’iniziativa decidono di vendere la propria azienda, monetizzando di fatto il lavoro di una o più generazioni. L’interazione del private banker rispetto al “liquidity event” può generarsi in momenti diversi, a seconda che egli sia stato coinvolto per generare la vendita, che sia stato chiamato in campo per la gestione delle garanzie collegate alla vendita (fideiussioni o escrow da rilasciare ai compratori) o per la gestione della raccolta. Il tema quindi non è solo l’allocazione del flusso di cassa generato dall’operazione, ma è connaturato ai bisogni che emergono a valle della vendita dell’impresa. Esistono, quindi, alcune fasi ben precise, con una cronologia determinata, che caratterizzano un’operazione di cessione di un’attività e di ciò che ne consegue».
I tre momenti che lei ha citato sono però fondamentali per caratterizzare il ruolo del private banker
«Sicuramente il credito relazionale nei confronti del cliente è direttamente proporzionale a quando il banker entra in campo. Se, attraverso la propria struttura, fa vendere l’azienda, trovando una controparte, gode di un credito maggiore rispetto a quello che gli verrebbe riconosciuto se entrasse a partecipare all’operazione all’ultimo miglio, perché cambia il livello di riconoscenza che l’imprenditore matura nei suoi confronti. È anche sicuramente importante governare le garanzie, soprattutto quando il partner è industriale e le offerte sono magari confluite a lui in modo diretto, evento che può facilmente capitare in un mercato aperto come quello del giorno d’oggi. Ovviamente, dal nostro punto di vista, la situazione ottimale è quella che vede il private vicino alla famiglia da tempo, che magari l’accompagna in un passaggio generazionale e che ha la possibilità di partecipare alle riflessioni che portano a una decisione importante come quella di cedere un’attività».
Ma la vendita di una società è particolarmente delicata e complessa perché tocca profondamente gli imprenditori.
«Si tratta di un momento che scatena le più diverse reazioni e alcune di queste sono molto profonde; lo posso dire per diretta esperienza professionale. Può sembrare controintuitivo, visto che il processo di vendita di una società è normalmente lungo, ma la giornata nella quale ci si trova davanti al notaio per formalizzare il passaggio di proprietà e incassare la contropartita economica concordata, è un momento in cui l’emotività delle persone coinvolte è altissima. È vero che nella circostanza viene formalizzata una decisione presa da tempo, ma le emozioni che si scatenano sono forti, palpabili e danno l’idea di quanto il livello di coinvolgimento dell’imprenditore sia profondo. Può essere di euforia, di sollievo (anche se in casi più limitati), ma anche di perdita di un punto di riferimento per colui che sino al giorno prima ha guidato un’attività economica con forti responsabilità sociali ben precise. Si sprigiona una serie di sentimenti che si protraggono per un periodo più o meno lungo, in base alla sensibilità di chi vende e delle ragioni che lo hanno portato alla vendita».
Nella cessione dell’attività, l’imprenditore rischia di vedere svuotato o ridefinito il proprio ruolo e ciò comporta anche ricadute psicologiche importanti, perché deve decidere come sarà la sua vita una volta conclusa l’operazione.
«Se si vuole guardare a una delle manifestazioni emotive che si possono manifestare, cioè il rammarico, evidenzierei la responsabilità che l’imprenditore sente rispetto ai propri dipendenti e nei confronti del territorio in cui opera. L’impresa crea valore, ovunque essa sia, e lo fa per le persone che vi lavorano e per l’area in cui è inserita e la sua comunità. Ad esempio, ho visto imprenditori, soprattutto quando sono partiti dalla provincia, che hanno impiegato parte delle proprie risorse e/o focalizzato alcune strutture dell’azienda per creare piani di welfare: dal finanziamento dell’asilo per i figli dei dipendenti, alle iniziative intraprese con i comuni in cui hanno sede le loro attività produttive. Se si unisce questo senso di responsabilità al fatto che, magari, l’impresa esiste da più generazioni, si capisce come tutto ciò possa creare un vuoto dentro, che non è solo economico, ma anche sociale».
Da questo punto di vista, diventa importante anche a chi vendere?
«È chiaro che vendere a un fondo di private equity, se non si ha l’obiettivo di raccogliere capitale per rientrare in possesso dell’azienda più avanti, dà un senso di precarietà e continuità diversa rispetto a un compratore industriale, che può offrire un futuro all’impresa, al di là del ruolo che l’imprenditore avrà al suo interno. C’è poi il tema, come è stato da lei sottolineato, di che cosa farà il proprietario di una società il giorno successivo alla sua vendita, perché c’è un pezzo di emotività che si protrae in ragione della situazione che si viene a creare. In altre parole, cambiano in modo significativo la posizione e la percezione nei confronti dell’imprenditore da parte dei nuovi soci, anche quando decide di rimanere operativo nell’impresa con ruoli apicali e deve gestire i nuovi equilibri relazionali che si sono creati. Se poi la vendita porta a una perdita di controllo dell’azionariato, diventa ancora più complessa la convivenza con il nuovo partner, soprattutto quando si tratta di fare scelte aziendali. Ho visto imprenditori che hanno deciso di vendere parte della loro attività e si sono poi trovati in difficoltà quando si è trattato di stendere piani di sviluppo, perché hanno dovuto fare i conti con il nuovo azionista. Ci sono invece casi in cui, se è un fondo che compera una partecipazione di minoranza, allora al proprietario, per quanto condizionato dai nuovi equilibri interni, rimane ampio spazio decisionale».
Che cosa cambia nell’imprenditore quando avviene un liquidity event?
«La “montagna di denaro” che viene generata ed entra nelle disponibilità dell’imprenditore spesso muta il modo in cui egli approccia la gestione delle proprie risorse, sia mobiliari, sia immobiliari. Inoltre, temi come la riservatezza, la diversificazione, la sicurezza e le aspettative di rendimento futuro hanno un peso influente nelle decisioni che vengono prese. Sono tutti aspetti delicati, forieri di dubbi e incertezze da sgomberare. Ci sono poi casi in cui l’imprenditore può decidere di rimettersi in qualche modo in gioco e investe in altre attività produttive. Solitamente ciò accade quando, anche all’interno della famiglia, esistono le condizioni per cui questa decisione può trovare una continuità».
Come fa un imprenditore a cambiare atteggiamento mentale, ossia smettere di ricoprire il precedente ruolo, e decidere come disporre della grande liquidità che si trova a disposizione?
«L’imprenditore, normalmente, è una persona avvezza a decidere e padrona del proprio destino. Il private banker che lo affianca lo aiuta a gestire il nuovo contesto in cui si trova, che in parte è già stato metabolizzato a monte della scelta fatta, quando ha deciso di vendere. Se ha ceduto il 100% della partecipazione, ha già messo in conto che non avrà futuro nella sua impresa. Può succedere che, parte del denaro ricevuto possa essere reinvestito in altre attività, magari introdotte dallo stesso compratore nel caso si tratti di un fondo di private equity. Il compito del private è aiutare il cliente a fare emergere i suoi bisogni, per capire come allocare al meglio la consistente liquidità ricevuta, aspetto quest’ultimo con cui l’imprenditore non ha sempre familiarità».
Le chiederei una riflessione sul detto che recita “la prima generazione di un’azienda costruisce, la seconda gestisce e la terza brucia”. Riscontra questa evoluzione nelle realtà imprenditoriali in cui si verifica un liquidity event?
«Direi che, nel contesto attuale, si tratta più di una leggenda metropolitana. Io mi occupo di private banking e non di corporate banking o contenzioso creditizio, ma posso dire che, in linea di massima, chi “brucia” le proprie risorse difficilmente riesce a monetizzare in modo significativo la cessione della propria azienda. I cambiamenti del mercato cui stiamo assistendo e la loro velocità hanno portato la classe imprenditoriale a fare scelte forti, per essere competitiva. Ho visto imprese in cui l’imprenditore è padre e padrone e non delega nulla ai figli, o altre in cui non c’è la possibilità di trovare figure idonee, all’interno della famiglia, per dare continuità alla gestione dell’impresa. Si tratta di casi delicati in cui, per una serie di ragioni diverse, non è possibile un passaggio generazionale e si procede così alla vendita dell’azienda. In generale, comunque, penso che le attuali condizioni di mercato, a differenza di quanto succedeva in passato, offrano diverse alternative all’imprenditore che si trova a decidere il futuro della propria attività».
Ci sono casi, invece, in cui un giovane imprenditore, a capo di una start-up o di un’azienda, è riuscito in un lasso di tempo circoscritto ad avere un grande successo?
«Sì, certo. Conosco casi dove, per ritornare alle riflessioni della domanda precedente, la nuova generazione che è subentrata alla guida dell’azienda ha portato grandi risultati economici e ha rafforzato in modo significativo il brand».
Nella gestione di un liquidity event, come si interfaccia il private banker con le altre figure professionali coinvolte?
«Non esistono modalità precostituite cui fare riferimento. Ci possono essere professionisti vicini alla famiglia che vengono coinvolti e altri che, invece, sono esclusi: sono commercialisti, avvocati, notai. La loro presenza o assenza è determinata da dinamiche di vario tipo, ciascuna da contestualizzare. Credo, però, che, all’interno di un processo, che io considero ottimale, il private banker debba essere colui che ingaggia le diverse figure professionali all’interno dell’accompagnamento nella gestione del liquidity event, in cui si deve rispondere alle esigenze del cliente in termini di riservatezza, sicurezza, aspettativa di rendimento, gestione del rischio. Ed è il private banker che, se è riuscito a costruire un rapporto fiduciario con il cliente, ha gli strumenti a disposizione e le risorse perché ciò avvenga nel migliore dei modi possibili. È indubbio che la fase iniziale di una cessione può essere di grande confusione, per le dinamiche anche emotive descritte, e poi perché, appena l’evento viene reso pubblico, si crea una lunga fila di professionisti che si propongono come partner per gestire l’allocazione della liquidità. Ho visto clienti “sfiniti” dai tanti contatti/proposte ricevute, tra cui anche quella di affidare a un soggetto terzo (family office) la gestione del patrimonio. In quest’ultimo caso, l’affidamento risponde alla scelta dell’imprenditore di disintermediare un’attività che non gli appartiene e che può metterlo in difficoltà».
C’è bisogno quindi di tanta cura nei confronti del cliente che vede cambiare le proprie prospettive future.
«Tanta cura, anche di carattere amministrativo: è un aspetto da non sottovalutare, se l’incasso viene fatto attraverso una holding o un trust, soprattutto quando si tratta di organizzare le attività future. E, proprio per tutte le ragioni qui argomentate, credo che il private banker possa essere il punto di riferimento per un imprenditore nel caso di un liquidity event, perché è la figura che ha potenzialmente gli strumenti per affiancarlo nelle decisioni da prendere, anche in discontinuità nei confronti del suo passato».