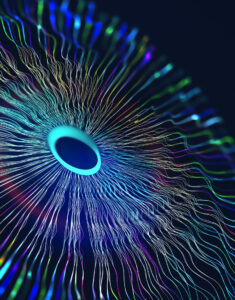Un’operazione di restituzione innovativa

La Fondazione Luigi Rovati, come recita il primo punto del suo manifesto, «è un’infrastruttura materiale e immateriale della società della conoscenza. Progetta e realizza processi e attività in aree diverse del fare cultura. Genera conoscenza, creatività e valore di utilità sociale». La sua presidente, Giovanna Forlanelli, racconta in questa intervista quale è stato il cammino che ha dato vita all’iniziativa e alla realizzazione del museo che ha aperto i battenti due anni fa in Corso Venezia a Milano.
Qual è lo spirito che ha guidato la costituzione della Fondazione Luigi Rovati?
«è stata non solo un’operazione di restituzione, ma anche la realizzazione di un’idea innovativa in un ambito diverso da quello farmaceutico, da cui proviene l’impresa di famiglia. Questa iniziativa si è articolata nel tempo, combinando esperienze manageriali e imprenditoriali ad alto contenuto scientifico, con quelle del mondo dell’arte, dell’industria culturale e dell’editoria. È la visione di una moderna filantropia da parte di una famiglia che estende il valore strategico del modello imprenditoriale alla cultura».
Chi è Giovanna Forlanelli?
«Mi sono laureata in medicina e chirurgia, con l’aspirazione di diventare chirurgo vascolare. Però, l’incontro con colui che sarebbe diventato mio marito, Lucio Rovati, impresse un cambiamento al mio percorso curricolare e fu così che decisi di lavorare per l’azienda della sua famiglia, la Rottapharm. La società fu fondata nel 1961, quando mio suocero Luigi Rovati, medico farmacologo, decise di abbandonare la carriera accademica all’Università di Pavia e di creare un proprio laboratorio di ricerca indipendente a Monza: Rotta Research Laboratorium. Era un medico illuminato, che ebbe la lungimiranza di lasciare il mondo accademico per impegnarsi nella ricerca farmacologica industriale. Nel 1986, quando entrai in azienda, fu aperta, in seguito a un’acquisizione, la filiale commerciale italiana del gruppo, la Rottapharm. Allora la mia attività era all’interno della direzione medica. Decisi poi di fare, per un anno, un’esperienza in una multinazionale di beni di largo consumo, dove acquisii delle competenze di marketing che mi permisero, ritornata in azienda, di riorganizzare la comunicazione medica: furono introdotti diversi cambiamenti veramente innovativi per quei tempi. Ma l’innovazione è sempre stata una caratteristica distintiva di Rottapharm, sin dalla sua nascita, insieme all’abitudine di pensare al di fuori degli schemi: è l’eredità che ci ha lasciato il suo fondatore e che la famiglia custodisce come insegnamento prezioso».
Com’è cambiato, nel tempo, il suo ruolo in azienda?
«Divenni responsabile della parte commerciale per i piccoli paesi dove si esportava direttamente, in particolare nel Centro America e nell’Estremo Oriente. Cominciai a girare il mondo e fu proprio durante i viaggi di lavoro che ebbi l’opportunità di visitare, durante il tempo libero, parecchi musei. Fu così che prese vita la mia passione per l’arte. Dopo la nascita di mia figlia, mi occupai del marketing per le filiali europee, ma, soprattutto, decisi di istituire il dipartimento di comunicazione corporate. In questo contesto, sviluppammo il programma di responsabilità sociale con una parte legata all’arte».
Perché questa particolare attenzione all’arte?
«Mio suocero era appassionato di arte antica, soprattutto bizantina e longobarda, e di numismatica; mio marito ha una passione per gli etruschi, mentre a me è sempre piaciuta l’arte contemporanea. È stato questo l’humus dal quale, alcuni anni dopo, è nata la Fondazione».
Tornando alla sua attività lavorativa, c’è stata innovazione anche nell’ambito della comunicazione?
«Rottapharm aveva esteso la sua attività anche al parafarmaceutico e con alcuni prodotti specifici iniziammo a creare percorsi per bambini alla scoperta dell’arte, con la realizzazione, ad esempio, delle prime audioguide loro dedicate. Nel frattempo a Monza, dove abbiamo la sede, siamo diventati lo stakeholder di riferimento per l’organizzazione di mostre aperte al pubblico, in collaborazione con le autorità comunali della città».
Eravate diventati sponsor di queste iniziative?
«Devo confessarle che non amo particolarmente questa definizione. La nostra famiglia non ha solo erogato fondi affinché un evento si potesse realizzare: il nostro approccio è sempre stato di creare progetti insieme ad altri e di portare la nostra managerialità all’interno del sistema culturale. Posso dire che, sotto questo punto di vista, siamo stati veri e propri pionieri».
In azienda avete conosciuto un passaggio generazionale. Come è avvenuto?
«Mio suocero affermava sempre di essere stato un uomo fortunato: si era laureato in medicina, aveva scoperto i suoi primi farmaci e li aveva fatti conoscere a livello internazionale. Ha dato linee guide molto rigorose, sia sul piano imprenditoriale, sia dal punto di vista dell’utilizzo della ricchezza, separando in modo molto netto le proprietà dell’azienda e quelle della famiglia. I suoi due figli entrarono nella società dalla porta di servizio, senza l’assunzione di ruoli apicali: mio marito è medico, specializzato in farmacologia clinica, e suo fratello è laureato in finanza. La diversa formazione accademica ha permesso loro di svolgere ruoli differenti all’interno della società: il primo nell’ambito dello sviluppo clinico dei farmaci e il secondo in quello amministrativo-finanziario. Le figure del direttore generale e dell’amministratore delegato sono sempre state esterne. Il passaggio generazionale è avvenuto quindi in modo molto naturale, perché pianificato e cementato da una serie di valori condivisi, tra i quali l’importanza attribuita alla funzione sociale della cultura».
Qual è stata poi l’evoluzione di Rottapharm?
«Nel 2014 è stata portata a termine la fusione di tutta la struttura commerciale, comprese le facility produttive, con il gruppo svedese Meda, di cui siamo diventati secondi azionisti. In seguito, questo gruppo è stato oggetto di ulteriori fusioni e acquisizioni e la nostra partecipazione si è diluita. Ora in Fidim, la holding di famiglia cui afferiscono tutte le nostre attività, che spaziano dall’immobiliare alla ricerca biotech, ciascun membro della famiglia ha trovato una sua collocazione in base alle proprie competenze e inclinazioni, compresi i membri della terza generazione che hanno portato una ventata di rinnovamento grazie alla loro sensibilità alla sostenibilità e all’ambiente. All’interno della nuova struttura societaria è stata stesa una governance che stabilisce in modo molto chiaro l’assetto patrimoniale tra i successori. Fidim è una società benefit dal 2015».
La passione per la ricerca farmaceutica vi è rimasta?
«Sì, ma non produciamo più direttamente farmaci: fungiamo in taluni casi da incubator e siamo presenti all’interno dei comitati scientifici di diverse società biotech, talora con alcuni investimenti. Anche in questo caso, abbiamo sviluppato un modello innovativo: la struttura di Rottapharm Biotech (è il nome dell’azienda), guidata da mio
marito Lucio Rovati, è composta da dirigenti superspecializzati che vedono tutte le fasi di sviluppo di un prodotto; ciò fa sì che la valutazione del dossier di un farmaco venga fatta a tutto tondo da esperti in materia».
Perché nasce la Fondazione?
«È un progetto che viene da lontano ed è stata realizzata quando si sono create le condizioni che mi hanno consentito di occuparmene. Le premesse perché ciò avvenisse erano state poste da mio suocero, che aveva avuto il desiderio di fare un atto di restituzione, ma non aveva trovato il tempo per concretizzarlo. Era sempre stato prodigo nell’aiutare gli altri attraverso opere di beneficenza ed era sensibile alla sostenibilità sociale, ma non aveva mai sviluppato un’operazione di filantropia strategica e chiese a me di farlo: un giorno mi disse che gli “avevo insegnato a donare”. Agli inizi fu l’organizzazione di mostre, di eventi, che mi vedevano coinvolta in prima persona. La mia passione per l’arte mi portò anche a fondare una casa editrice, la Johan & Levi Editore. La presenza in azienda di due figli ha fatto sì che si potesse intraprendere una serie di iniziative, tra le quali, appunto, la costituzione nel 2016 della Fondazione Luigi Rovati, i cui soci fondatori sono mio marito, mia figlia e io: è sostenuta da tutta la famiglia e ne è un punto di riferimento. Attualmente ne sono la presidente e ho trasferito in essa la mia competenza manageriale: ho creato uno staff molto giovane, ma molto partecipativo, che nel tempo possa autonomamente condurre la Fondazione, in attesa dell’eventuale coinvolgimento delle nuove generazioni».
Cosa comporta la gestione manageriale di una fondazione?
«Significa trasferire alla fondazione un metodo di lavoro che rispecchi una visione strategica “aperta”, con un sistema di relazioni e alleanze con soggetti diversi, istituzioni e imprese che producono, a loro volta, una serie di attività condivise. Un punto di incontro e di sviluppo che genera creazione e inclusione, che confluiscono nel valore di utilità sociale. Amo definirla una startup culturale nata con l’obiettivo di sviluppare un progetto museale che fosse veramente innovativo».
Ed ecco che ritorna l’innovazione, il filo rosso che lega la vostra storia imprenditoriale e familiare. Come nasce concretamente il museo?
«Avevo seguito i primi osservatori digitali culturali del Politecnico di Milano; ero presente allora, come oggi, nel comitato consultivo della collezione Peggy Guggenheim ed ero molto vicina a diverse realtà museali, tanto da conoscerne il meccanismo e il funzionamento. Fu così che, insieme a mio marito, decisi di realizzare la Fondazione con il museo d’arte a Milano, cercando di formulare una proposta che andasse a riempire un vuoto d’offerta a livello culturale nella città: fu individuata nell’archeologia. Iniziò un lavoro di preparazione molto articolato, che consistette nella stesura del progetto, nella determinazione della sua finalità ultima, benché fosse già stato deciso che dovesse essere di natura sociale, e nell’individuazione del luogo dove il museo sarebbe stato realizzato e la fondazione avrebbe avuto la sua sede».
Un lavoro quasi fatto a tavolino?
«Un impegno dove nulla è stato lasciato al caso, frutto di profonde riflessioni e confronti su come formulare e comunicare la nostra proposta culturale. Abbiamo inoltre elaborato un modello di lavoro a rete, cercando fin dall’inizio collaborazioni con le università e con tutti gli stakeholder che potevano aderire all’iniziativa. Ci siamo dati una struttura aperta che accoglie progetti dall’esterno e propone all’esterno i propri progetti. Il metodo adottato è elastico e genera applicazioni articolate: attività sulle proprie collezioni, mostre ed eventi, attività di studio, di ricerca, di formazione, di documentazione e di divulgazione. I principi operativi che ispirano la fondazione sono definiti da otto codici che ne costituiscono la base del linguaggio e dell’azione: la conoscenza, l’espansione, l’inclusione, la creazione, lo spazio, l’estetica, la relazione e l’utilità sociale. Il nostro scopo è rendere la cultura un elemento inclusivo per tutti: visitare un museo deve essere visto come un’attività consuetudinaria in un luogo che accoglie chi vi si reca. Ed è proprio per questa ragione che vorremmo misurare l’impatto sociale che esso ha sulle persone, un tassello fondamentale per dimostrare l’importanza di queste iniziative e per offrire un riscontro tangibile anche a chi le vorrebbe sostenere».
È un altro obiettivo sfidante?
«Stiamo lavorando all’individuazione dei parametri da adottare per rendere ciò possibile e lo stiamo facendo in collaborazione con altre fondazioni, andando oltre i parametri Esg, che sono già adottati al nostro interno. È un lavoro complesso, perché si tratta di misurare il benessere di un individuo. Un tema molto importante per noi è l’inclusione: stiamo sviluppando un grande progetto, che abbiamo chiamato “Museo gentile”. Da una parte abbiamo realizzato alcuni percorsi per accogliere persone con fragilità e necessità particolari, in autonomia o insieme ai loro familiari, amici e care-giver. Ma un progetto ancora più importante è lo studio del rapporto tra attività culturali e benessere nelle persone sane. Avendo a disposizione la struttura della società di ricerca del gruppo, c’è la possibilità di usarne il know-how e utilizzarlo all’interno di questa iniziativa. Così facendo, il museo stesso sta diventando il centro di ricerca di questo progetto sperimentale che andrà a misurare, nell’individuo sano, parametri fisiologici o biologici».
Per voi la sostenibilità e l’impatto della vostra attività sono aspetti cruciali?
«Sono elementi distintivi delle nostre attività e di come ci presentiamo agli altri. Abbiamo prestato particolare attenzione alle modalità con cui è stato riqualificato l’edificio, ai materiali utilizzati, al consumo delle risorse impiegate per il suo funzionamento e alla gestione del personale, composto da giovani mediatori culturali che siamo riusciti a motivare tanto da farli sentire partecipi del nostro progetto. Sono attivi e disponibili anche nei confronti dei visitatori, con i quali instaurano un rapporto dal quale nasce una scoperta reciproca. Un museo, oltre a essere un centro di ricerca, studio e valorizzazione del patrimonio culturale, deve offrire una serie di servizi per il pubblico, ma deve essere anche un luogo d’incontro, come una volta lo erano le biblioteche. Certo, le forme di socializzazione e comunicazione sono cambiate ed è per questo motivo che abbiamo cercato di trovare nuove modalità per esporre l’archeologia. Vogliamo creare momenti di inclusione sociale ed è per questa ragione che, ad esempio, nel padiglione esterno organizziamo mostre gratuite e vorremmo che diventasse un luogo in cui le persone possano trovare un momento di approfondimento e di piacere ogni qualvolta lo desiderino durante la giornata».
Perché un museo etrusco?
«Mio marito, come già accennavo, ha la passione per l’arte etrusca e ciò lo aveva portato ad avere una piccola collezione, non sufficiente però per fare un museo. La realizzazione di quest’ultimo ci ha poi portato ad ampliare la collezione museale con acquisti di collezioni residenti in Italia o all’estero, riportando così nel nostro Paese reperti del nostro patrimonio. Infatti, lavoriamo con etruscologi, abbiamo promosso ricerche su questa civiltà e siamo convenzionati con le università dove si studia il tema. Indubbiamente, il fatto di essere un museo di collezioni ci ha permesso di trovare modalità espositive diverse, dove non necessariamente l’oggetto deve essere contestualizzato nel luogo del suo ritrovamento, e di creare situazioni di contaminazione con l’arte contemporanea. Quest’ultima è stata una scelta di gusto personale, ma anche mossa dalla convinzione che l’arte contemporanea debba servire a leggere l’antichità e l’archeologia a comprendere la contemporaneità».