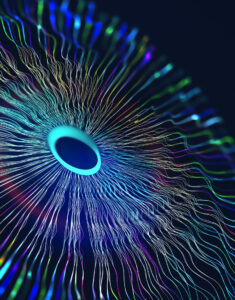Longevità attiva
 L’evoluzione demografica del nostro Paese richiede una serie di riflessioni ponderate che riguardano la società nella sua interezza. Interrogarsi su quale sarà la sostenibilità dell’attuale modello di sviluppo è quindi più che mai doveroso di fronte a una popolazione che invecchia: è un tema che si muove all’interno di un contesto di complessità, con molti nodi da sciogliere che richiedono uno sforzo collettivo da parte, sia delle istituzioni, sia dei singoli individui. Be Private ha intervistato sull’argomento Paolo Gila, giornalista e scrittore economico-finanziario.
L’evoluzione demografica del nostro Paese richiede una serie di riflessioni ponderate che riguardano la società nella sua interezza. Interrogarsi su quale sarà la sostenibilità dell’attuale modello di sviluppo è quindi più che mai doveroso di fronte a una popolazione che invecchia: è un tema che si muove all’interno di un contesto di complessità, con molti nodi da sciogliere che richiedono uno sforzo collettivo da parte, sia delle istituzioni, sia dei singoli individui. Be Private ha intervistato sull’argomento Paolo Gila, giornalista e scrittore economico-finanziario.
Le aspettative di vita sono aumentate, ma il nostro sistema di welfare è sostenibile?
«I dati dell’Istat certificano l’erogazione 17.775.000 pensioni di cui 13.632.000 di previdenza e 4.142.000 di assistenza. Tuttavia, le prestazioni pensionistiche sono di più, ossia quasi 23 milioni, perché molti pensionati ricevono un doppio vitalizio. Il costo complessivo è di circa 350 miliardi di euro: circa 270 miliardi sono la spesa pensionistica, il resto per l’assistenza. Diversi studiosi hanno da tempo sottolineato la necessità di separare le due voci nella contabilità dello stato, perché è dalla loro somma che nascono le maggiori criticità per il nostro sistema pubblico. Mantenere una distinzione renderebbe possibile una visione di politica economica più adeguata ai tempi e alla struttura della società che si è venuta a creare. Infatti, la spesa per le pensioni e l’assistenza è circa la metà del budget statale: un peso consistente per i conti pubblici che contribuisce a generare il disavanzo pubblico».
È una situazione che richiede notevoli interventi. Che cosa ne pensa?
«Non mi voglio arrogare un ruolo che non mi compete, visto che tocca al legislatore e agli esperti in materia disegnare le migliori traiettorie per salvare i conti pensionistici. Tuttavia, è importante averne contezza e, a tale proposito, vorrei fornire ulteriori dati che sono utili a descrivere il contesto attuale e a capirne la conformazione. Oggi ci sono 400 mila percettori di pensione che ricevono mensilmente un assegno superiore a 5 mila euro, mentre per 4,8 milioni di individui l’ammontare è inferiore a 1.000 euro. Al carico pensionistico contribuiscono 24 milioni di lavoratori: 16 milioni sono dipendenti, quasi 3 milioni hanno contratti a termine e 5,23 milioni sono autonomi, il cui peso sta gradualmente aumentando (partite Iva, piccoli artigiani, mono-imprese). A questo quadro si aggiunge un dato importante rilevato sempre dall’Istat: l’occupazione dei giovani tra i 24 e i 30 anni è in calo. Quest’ultimo è l’elemento di criticità che si aggiunge a una spesa pensionistica crescente: al monte delle risorse dell’Inps stanno contribuendo soprattutto le fasce medie e medio-anziane dei lavoratori. La sostenibilità del sistema pensionistico è in funzione di queste variabili, che ne determineranno l’evoluzione futura. La traiettoria dei costi rispetto alle risorse, stando così le cose, nel medio-lungo termine potrebbe preoccupare visto che la nostra società sta andando incontro a un inverno demografico: nel prossimo quarto di secolo la popolazione potrebbe diminuire almeno di altri 4 milioni di abitanti».
Quali considerazioni possono emergere dal quadro che lei ha descritto?
«Traspare evidentemente la necessità di apportare una serie di correzioni e aggiustamenti. Gli economisti sostengono che si dovrebbe aumentare la crescita: un Pil più elevato genererebbe ricchezza per il Paese, produrrebbe un reddito medio più alto e diffuso e le casse pubbliche potrebbero essere più gonfie per le maggiori entrate fiscali. Si tratta, fuor di dubbio, di un elemento importante per valutare la sostenibilità di un sistema come quello italiano. Però, se analizziamo nel dettaglio la situazione, emergono anche alcuni dati abbastanza curiosi. Attraverso uno studio che ho fatto con l’Active Longevity Institute (Ali), una società cui collaboro e che ho contribuito a fondare, ci sono in Italia alcuni individui che, pur avendo superato i 65 anni e pur percependo una pensione, continuano a lavorare: sono circa 840-880 mila persone che rappresentano l’1,35% della popolazione totale. I dati sono stati raccolti attraverso fonti pubbliche: Istat, Inps, associazioni professionali. All’interno di quest’ultima categoria, il panorama è ampio e variegato e popolato da persone che sono ancora vivaci dal punto di vista dell’attività: dagli avvocati agli artigiani, dai medici agli agricoltori per arrivare agli artisti. Ci sono ambiti, nei quali tipicamente non si fanno lavori usuranti, in cui le persone seguitano a svolgere un’attività per necessità o per passione, ma anche per mantenere delle relazioni, perché si considerano, da un punto di vista interiore, spiriti sociali e non individualisti».
Come si possono definire queste persone?
«Sono i cosiddetti longevi attivi: lavorano, pagano le tasse e anche i contributi previdenziali, senza però che questi ultimi vadano ad alimentare il loro assegno pensionistico, che sarà rivisto solo dopo un certo numero di anni alla luce dell’attività svolta. Contrariamente a ciò che si pensa, c’è una parte della popolazione anziana che contribuisce al bilancio pensionistico. Si tenga presente che, da un punto di vista demografico, le persone che in Italia hanno più di 65 anni sono 14,177 milioni (un italiano su quattro), tra i 65 e gli 80 anni sono 9,7 milioni (un italiano ogni sette) e oltre gli 80 anni sono 4,5 milioni (un italiano su 14): i dati, in termini percentuali corrispondono rispettivamente al 24,1%, 16,4% e 7,7% della popolazione totale. Sono cifre sulle quali occorre fare una profonda riflessione. È proprio guardando questi numeri che la domanda sulla tenuta del sistema previdenziale attuale risulta più che mai lecita e fondata».
C’è quindi il problema, soprattutto per le generazioni più giovani, di come strutturare il proprio piano previdenziale. Quali sono le sue osservazioni in merito?
«Con l’introduzione della legge Fornero, è iniziata la progressione verso un sistema pensionistico contributivo, ossia un’assegnazione legata al montante accumulato durante la vita lavorativa. Le persone la cui pensione verrà interamente calcolata in questo modo, i giovani in particolare, avranno bisogno di integrare il loro assegno pensionistico o attraverso la categoria di appartenenza o, meglio ancora, con l’aggiunta di un terzo pilastro, ossia una previdenza integrativa basata sulle scelte individuali. È un percorso che le giovani generazioni dovranno perseguire».
Ritornando invece ai longevi attivi, ci sono alcune politiche che possono facilitare queste persone a esprimere la loro vivacità come soggetti partecipi del contesto economico e sociale?
«Per quanto riguarda l’aspetto economico, l’attività lavorativa è fatta non solo di macchine, prodotti, uomini, ma anche di cultura. Quest’ultima è il risultato degli studi che i singoli lavoratori hanno compiuto e dell’esperienza che hanno accumulato. In alcuni paesi, come la Germania, l’Olanda o la Francia, le aziende stanno associando in gruppi di lavoro persone appartenenti ad almeno tre fasce d’età: i giovani sino ai 35 anni, la componente intermedia sino ai 55 e gli individui più anziani. Da questa organizzazione è emerso che, dal punto di vista psicologico, i giovani sono i più attivi perché hanno le conoscenze informatiche e tecnologiche che i senior non hanno, ma questi ultimi sanno come risolvere i problemi grazie alle esperienze vissute. La fascia di mezzo è quella che fa da cerniera tra le altre due generazioni e assorbe da entrambe le diverse competenze. In questo modo viene garantita all’interno delle aziende una continuità e contiguità tra gli appartenenti a questi gruppi. Si tratta di una filosofia manageriale chiamata Age management, cioè una gestione del personale che consideri le fasce d’età, le conoscenze e l’esperienza. Questo è un modo di pensare che in Italia è disatteso, anche se sarebbe auspicabile che ci fosse un motore di cultura che spingesse verso la comprensione di modelli capaci di attuare le compresenze e gli sviluppi valoriali tra le varie generazioni. Ci sono imprese nelle quali, dopo i 60 anni, il personale viene parcheggiato in una sorta di “cimitero degli elefanti” o viene esautorato da una serie di responsabilità. Bisogna pensare a un diverso modello di organizzazione del lavoro recependo le esperienze virtuose che arrivano dall’esterno. In merito, invece, all’aspetto sociale, attraverso Ali ho lanciato la proposta di istituire una sorta di tutor della longevità. In altre parole, se non è possibile istituire un ministero della demografia, perlomeno che nasca una figura che abbia il compito di interloquire con le istituzioni per rappresentare gli interessi e i valori di questa parte della società che è attiva lavorativamente e che ha, tra i suoi collaboratori, dei giovani che aiuta a crescere».
Potrebbe portare alcuni esempi concreti?
«Personalmente conosco un artigiano che realizza camicie sartoriali in Abruzzo e che, non avendo figli e non avendo trovato lavoratori in grado di collaborare con lui, sta trasferendo le sue conoscenze a una persona proveniente da un’altra nazione (India) con l’accordo che quest’ultima si farà carico di continuare l’attività aziendale. C’è poi il caso di uno stilista di 77 anni, con lunghi rapporti di collaborazione con i grandi marchi della moda italiana, che due anni fa ha deciso di mettersi in proprio per dare corpo a diversi progetti che aveva in mente di sviluppare. Attualmente sta realizzando alcune nuove linee di accessori uomo e partecipa alle fiere di settore con il proprio marchio. Sono storie di vita vissuta, così come quella di un manager che era stato amministratore delegato di grandi gruppi del settore automotive e, dinnanzi a un lutto familiare, si è trovato di fronte a diverse opzioni, tra cui iniziare a godere della ricchezza che aveva accumulato. Ma la scelta è stata diversa: la volontà di reagire al dolore che lo aveva colpito lo ha portato, all’età di 73 anni, a fondare una società di design, che ha poi aperto uffici in Italia, Cina e negli Stati Uniti. Solo oggi, a 80 anni, ha deciso di posare la valigia e di non girare più per il mondo, pur continuando ad amministrare il proprio gruppo fatto da giovani capaci, volonterosi e creativi. Tutto ciò per sottolineare che in Italia ci sono individui che non smettono di contribuire al senso della bellezza e della ricchezza del Paese che, come essi stessi affermano, ha dato loro molto. Sono numerosi i casi di persone sopra i 65 anni che hanno un’esperienza manuale da potere tramandare. Da qui la regola, a mio parere, che sarebbe opportuno che anche i giovani, oltre agli studi teorici, avessero simili competenze».
Ma il contesto italiano vede una fuga della mano d’opera, soprattutto giovanile, all’estero. A chi si trasferiscono le competenze?
«In Italia c’è un’esportazione di cervelli, perché gli stipendi non sono equiparabili a quelli di altri paesi europei: stiamo assistendo a un’emigrazione di professionisti di alto profilo e a un’immigrazione che non sempre presenta le stesse caratteristiche. Ma le nostre imprese, perlopiù Pmi che esportano sui mercati internazionali, hanno bisogno di tecnici, ma anche di manager che sappiano organizzare il lavoro e la produzione. Si sta assistendo a un corto circuito tra la domanda e l’offerta di qualità professionali, con una quota di giovani che non studia e non lavora. Assisteremo, molto probabilmente, nei prossimi anni, a una penuria di competenze per diverse filiere produttive: sarà un altro problema sempre collegato a questa dinamica demografica, con le ricadute che ne conseguono».