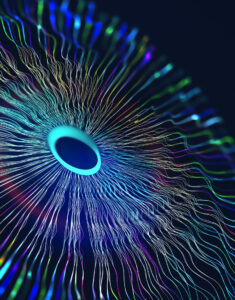Una popolazione che invecchia
 L’Italia è tra i Paesi anagraficamente più vecchi al mondo: le stime Istat indicano che entro il 2050 la popolazione si ridurrà dai circa 59 milioni attuali a 52,7 milioni di abitanti nello scenario peggiore, a 54,8 milioni di abitanti nello scenario mediano e a 57,0 milioni di abitanti nello scenario migliore a causa di un basso tasso di natalità e di uno di mortalità che è destinato ad aumentare. A parlare di questi temi è Andrea Furcht, docente a contratto di Demografia all’Università Cattolica di Milano.
L’Italia è tra i Paesi anagraficamente più vecchi al mondo: le stime Istat indicano che entro il 2050 la popolazione si ridurrà dai circa 59 milioni attuali a 52,7 milioni di abitanti nello scenario peggiore, a 54,8 milioni di abitanti nello scenario mediano e a 57,0 milioni di abitanti nello scenario migliore a causa di un basso tasso di natalità e di uno di mortalità che è destinato ad aumentare. A parlare di questi temi è Andrea Furcht, docente a contratto di Demografia all’Università Cattolica di Milano.
Si sta innalzando l’età media della popolazione o siamo semplicemente più vecchi?
«Per entrare nel merito della sua domanda, è necessario fare un distinguo: c’è l’invecchiamento individuale, cui tutti siamo soggetti; c’è quello collettivo che teoricamente è reversibile, perché una popolazione potrebbe ringiovanire attraverso una diminuzione nel tempo dell’età media. Non è certo quanto sta succedendo ora, ma non è neppure escluso che questo fenomeno si manifesti transitoriamente tra qualche decennio».
Mi scusi, ma mi sembra difficile da immaginare. Come sarebbe possibile?
«C’è un gran numero di nati nel baby-boom del dopoguerra. Possiamo immaginare questa generazione come un’ondata di piena che nel tempo percorre progressivamente tutte le età: negli anni ’50 e ’60 era un fattore di ringiovanimento, mentre adesso sta portando l’età media verso l’alto. A un certo punto si assottiglierà sino a estinguersi, lasciando dietro di sé un equilibrio meno sbilanciato: possiamo immaginare che la popolazione sopra i 65 anni toccherà il suo massimo tra una ventina d’anni; in quanto alla sua incidenza, molto dipende da un’eventuale contestuale attenuazione del declino della popolazione più giovane. Ma, ripeto, si tratterebbe di un effetto di passaggio: nella sostanza, l’invecchiamento della popolazione permarrà. Detto ciò, ci sono due modi per invecchiare collettivamente: il primo è che si muoia sempre più tardi, il secondo è il cosiddetto invecchiamento dal basso, ossia che si nasca di meno. Se si vive più a lungo significa che si corrono meno rischi a tutte le età, ma anche che, grazie a condizioni di vita in miglioramento, il declino finale pare presentarsi più tardi».
Come è evoluta la situazione nel tempo?
«Secoli fa si moriva e si nasceva tantissimo, perché questo era il destino segnato dalla natura. La speranza di vita era quindi molto bassa: la morte era in agguato a tutte le età, ma, soprattutto, circa la metà dei nati non riusciva a sopravvivere all’infanzia. Quando si afferma che la vita media storicamente era intorno ai 30 anni, significa che c’era una forte incidenza della caducità della popolazione infantile, non che i trentenni fossero allora dei vecchi. Con il trascorrere dei secoli, i Paesi più ricchi, e poi gli altri a cascata, conobbero la cosiddetta “transizione demografica”. In altre parole si cominciava a morire meno grazie alla modernizzazione: si pensi alla rivoluzione industriale, con il conseguente arricchimento, i miglioramenti nei trasporti, nel commercio e nelle conoscenze scientifiche, soprattutto mediche a partire dall’introduzione dei vaccini. Una volta aumentata molto la popolazione, il minore numero di morti venne controbilanciato da nascite più contenute».
Ma perché è diminuito il numero delle nascite?
«Dal punto di vista individuale dei genitori, la transizione demografica è stata interpretata come uno spostamento delle proprie risorse sui figli privilegiando la qualità alla quantità. In altra ottica, possiamo pensare che la prole nelle società tradizionali fosse una risorsa, paragonabile a un bene d’investimento; in quelle contemporanee, invece, i figli sono, dal punto di vista dell’analisi economica, beni di consumo. Mi rendo conto che può sembrare una definizione un po’ cinica, ma è migliore di quanto non appaia: in questo contesto, “bene di consumo” indica che i figli sono un valore in sé e non uno strumento per ottenere vantaggi economici. Da un punto di vista sistemico, constatiamo che il calo della mortalità, specialmente infantile, ha innescato una sorta di compensazione: si sono dati alla luce meno figli perché avevano più possibilità di sopravvivere. Si può affermare che, dal ‘700 in poi, le popolazioni nel mondo sono cambiate, prima quelle europee e le altre a seguire; alla fine persino molti Paesi di quello che decenni fa veniva chiamato “Terzo mondo” hanno visto drasticamente scendere il numero di figli per coppia, processo di trasformazione che è ancora in atto. Attualmente, quasi tutte le nazioni mostrano una fecondità in discesa, per quanto a volte ancora altissima».
Che cosa s’intende per fecondità?
«La fecondità misura la riproduzione effettiva pro capite della popolazione e ha un ruolo importante nel configurare la sua struttura. Il termine va distinto da fertilità, che indica la capacità biologica di avere figli, che può essere inibita principalmente dall’età, in particolare nelle donne. Curiosamente, in inglese “fertility” e “fecundity” hanno significati invertiti, da cui frequenti confusioni lessicali. Un altro concetto da chiarire è “natalità”: si tratta del rapporto annuale tra il numero dei nati vivi e la popolazione che li origina. L’ottica è quindi più collettiva che non quella della fecondità, orientata invece ai comportamenti individuali. La natalità è infatti influenzata dalla struttura per età: a parità di figli per coppia, misurati dalla fecondità, una popolazione invecchiata farà meno figli di una più giovane, perché meno numerose saranno le madri potenziali».
Il calo odierno della fecondità è sempre da legare al processo di modernizzazione?
«Va contestualizzato nelle diverse aree geografiche e al loro processo di sviluppo storico-economico. Alla modernizzazione si deve il grande salto da molti figli pro capite delle società preindustriali a uno-due per coppia di oggi; adesso, però, nei Paesi più sviluppati, ma anche in alcune economie emergenti, contano probabilmente più i fattori congiunturali e le aspettative. Oppure, come si accennava, possiamo darne un’interpretazione sistemica di correzione dei grandi aumenti del passato».
Qual è la situazione attuale?
«Secondo il contatore demografico sul sito Neodemos, in questo esatto momento la popolazione mondiale è di 8.134.060.212, mentre quella italiana è di 58.644.285. C’è una previsione dell’Onu secondo la quale nel 2100 saremo 10,2 miliardi di persone, un dato che fa impressione, ma che indica già una discesa rispetto a 10,3 miliardi del 2085. Si noti che questa previsione riduce le stime rispetto a quelle pubblicate precedentemente; nel 2020 era inoltre uscito sulla prestigiosa rivista scientifica Lancet un importante studio che preconizza un picco di 9,7 miliardi nel 2064 e un livello di 8,8 al 2100».
Ma potrebbe cambiare?
«Dipenderà da quanti figli a testa le persone vorranno fare (la fecondità), salvo l’occorrenza di catastrofi (naturali o belliche), anche se il loro impatto sui grandi numeri è spesso più contenuto di quanto non si possa immaginare».
Quali sono le conseguenze di una sempre maggiore presenza di persone anziane all’interno della popolazione?
«La maggiore presenza di anziani, per quanto le loro condizioni fisiche possano essere migliori dei loro antenati, sta già producendo conseguenze significative. Sicuramente, ci sarà un maggiore bisogno di assistenza sanitaria e anche il sistema pensionistico dovrà adeguarsi ai cambiamenti demografici: ciò potrebbe essere molto doloroso, perché diventerà sempre meno generoso. Ma questa previsione è cosa nota. Ciò su cui vorrei porre l’attenzione è come leggere quello che viene definito come “inverno demografico”, che riguarda soprattutto le economie avanzate, ma anche alcune di quelle di paesi non-Ocse, come la Cina o la Russia. Quando, contestualmente all’invecchiamento, diminuisce la popolazione, da un lato si contrae la forza lavoro e, dall’altro, cala anche la domanda. Da un punto di vista astratto, se, a fronte di una diminuzione della popolazione la produzione calasse proporzionalmente, la ricchezza pro capite non cambierebbe. Tuttavia, l’invecchiamento dei lavoratori ha conseguenze sulla qualità della produzione, e soprattutto sulla capacità di innovare. Inoltre, le dimensioni contano per la capacità d’investimento e, ancora di più, di innovazione tecnologica, come ben descritto nel recente Rapporto Draghi. Agiscono, inoltre, altre economie di dimensione, che giocano un ruolo che è l’equivalente sociale dei costi fissi d’impresa. Un discorso a parte va fatto per la potenza nazionale: chi in senso relativo rispetto agli altri stati perde popolazione diventa più fragile da un punto di vista non solo militare, ma anche in termini di capacità economica e di egemonia culturale. A mio parere, credo che le ansie legate all’“inverno demografico” possano essere altresì spiegate dal timore di perdere rilevanza. Anche se pochi lo ammetterebbero apertamente, il retropensiero è augurarsi un rafforzamento demografico del proprio Paese, nel contesto di un mondo che invece almeno fermi la propria crescita. Tutto ciò soprattutto alla luce della questione ambientale».
Perché cita la questione ambientale?
«Esiste un semplice modello, chiamato Ipat, che descrive l’impatto ambientale: quest’ultimo (I) è il risultato della moltiplicazione della popolazione (P) per la ricchezza pro capite (A= affluence) per la tecnologia (T), considerata all’inverso (quando questa progredisce permette di diminuire l’inquinamento, compensando pertanto gli effetti negativi di P e di A). Da qui, la conclusione molto semplice che una popolazione più elevata, a parità di altre condizioni, inquina di più. E devo dire, per inciso, che rimango perplesso sul perché non si parli di questo aspetto quando si toccano i temi ambientali: forse perché così le responsabilità del cosiddetto Nord del mondo verrebbero ridimensionate. Infatti, anche aumentare troppo è un problema e si porta appresso una serie di ricadute economiche e sociali. A livello planetario, un mondo più affollato potrebbe essere più propenso ai conflitti, anche senza considerare il fatto che le società più giovani tendono a essere più violente».
Quindi non è preoccupato dall’inverno demografico?
«Non sono così terrorizzato, per quanto ne veda i pericoli, specialmente a breve-medio termine. Può darsi che nel lungo periodo l’umanità stia meglio con una popolazione inferiore a quella di oggi. Come spesso avviene, le fasi di passaggio sono più dolorose degli equilibri finali».
Tuttavia, come si rimedia all’invecchiamento della popolazione?
«Prendiamo la situazione italiana: secondo i dati Istat del 2023, nel nostro Paese un ottavo della popolazione è sotto i 14 anni, poco meno di due terzi tra i 15 e i 64 anni e quasi un quarto sopra i 65. Uno dei rimedi più invocati è l’immigrazione, per fornire al mercato del lavoro le nuove leve di cui ha bisogno. Si tratta di una questione molto complessa: mi limito a fare notare che è fondamentale guardare anche al tipo di apporto che i nuovi arrivati potranno dare, non solo alla loro consistenza numerica. È naturalmente molto grave che nel contempo molti giovani italiani, oltretutto tra i più preparati, emigrino all’estero.
Ed è fondamentale, naturalmente, che si rialzi la fecondità, anche se agirebbe su contingenti ridotti di genitori potenziali; e, comunque, i nuovi nati arriverebbero sul mercato del lavoro dopo almeno una ventina d’anni. Una delle soluzioni, di cui si è già parlato, è aumentare su base volontaria le opportunità di impiego meno usuranti per gli ultrasessantenni, anche attraverso forme miste di collaborazione che la digitalizzazione rende oggi possibili. Il caso del telelavoro è particolarmente utile, da questo punto di vista, perché la tecnologia può aiutare anche, e forse soprattutto, chi non è giovane. Quanto all’incompetenza digitale degli anziani, andrà diminuendo: si tratta infatti di un effetto di generazione, legato all’età solo transitoriamente».
Di che cosa si tratta?
«Quando ero bambino, molti anziani erano analfabeti e parlavano solo il dialetto. Questa non è una caratteristica generale dei vecchi, ma di chi lo era in quegli anni: erano così anche da giovani. Oggi, gli individui della stessa età sono molto diversi dai loro coetanei del passato, appunto perché appartenenti a generazioni successive. Esistono naturalmente anche effetti d’età veri e propri, legati soprattutto al declino psicofisico, ma anche a determinati ruoli sociali, quali essere in pensione o diventare nonni.
Viviamo in un’epoca di grande preoccupazione, non solo per l’incombente inverno demografico, ma anche per le prospettive inquietanti del progresso, in particolare della sua punta di diamante rappresentata in questo momento dall’intelligenza artificiale. Eppure, è proprio la tecnologia la risorsa ideale per accompagnare una forza lavoro in declino quantitativo: l’opportunità di lavorare senza eccessivo logoramento fisico, il fatto di importare grazie al telelavoro servizi dall’estero anche senza presenza fisica dei lavoratori e, soprattutto, la speranza di una produttività in grande ascesa nel tempo ci consentono di conservare speranze per un futuro migliore. Del resto, nel lungo periodo, la tecnologia è sempre stata alleata dell’umanità».