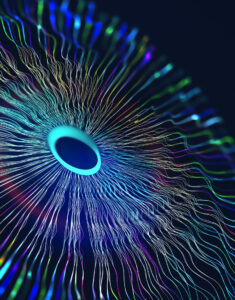Usa e Cina: una relazione difficile

I rapporti tra Cina e Usa si stanno deteriorando, animati dal sospetto e dalla sfiducia reciproca. La Repubblica Popolare è l’unico paese che può sfidare gli Stati Uniti, che non vogliono un mondo multipolare. Jacob L. Shapiro, chief strategist di Perch Perspectives affronta questo delicato tema con Be Private.
Qual è lo stato attuale delle relazioni tra Stati Uniti e Cina?
«Ritengo che sia in una condizione particolarmente negativa. Nel 2008 si era assistito a un vero e proprio coordinamento tra il dipartimento del Tesoro americano e la Banca centrale cinese per arginare gli effetti della crisi finanziaria globale. L’impegno, allora, era stato realizzare uno sforzo congiunto con un obiettivo condiviso: l’economia mondiale. Lo stesso tipo di collaborazione, però, non si è certamente ripetuto con il Covid-19, perché, anziché arrivare a una pandemia, sarebbe stato forse possibile contenere la diffusione del virus a livello endemico. C’è stato un momento, lo scorso giugno, dove si è cercato di assumere un atteggiamento più pragmatico nelle relazioni con la Cina e discutere la possibilità di rivedere l’imposizione delle tariffe introdotte da Trump, ma la decisione di Nancy Pelosi di andare in visita a Taiwan ha aperto un’altra crisi tra i due paesi. Da allora, credo che la relazione tra Cina e Usa si sia deteriorata, lasciando spazio, all’interno dell’amministrazione, alle posizioni più intransigenti nei confronti di Pechino. L’ elemento doppiamente scoraggiante è che, mentre a Washington non si riesce a trovare praticamente alcun accordo a livello politico, l’unico punto sul quale c’è un consenso bipartisan è proprio il giudizio negativo nei confronti della Cina. Al momento, non vedo segnali che vadano in direzione di un miglioramento delle relazioni, anzi, sono in peggioramento».
Le elezioni di metà mandato hanno condizionato questo tipo di atteggiamento?
«È indubbio che la politica domestica giochi un ruolo, ma sono la sfiducia e il sospetto che animano le relazioni tra i due stati. La Cina ha giocato un ruolo importante nella psicologia degli americani per circa un secolo. È l’unico paese al mondo rivale degli Stati Uniti più grande di loro, con una popolazione più numerosa e che ha più accesso alle risorse. Durante i conflitti passati, i nemici degli Usa, come l’Unione Sovietica, la Germania o il Giappone, erano dimensionalmente più piccoli e incapaci di competere con l’economia americana. La Cina è la sola nazione che può realmente sfidarli. La lettura geopolitica di ciò è che gli Stati Uniti non vogliono vivere in un mondo che sia multipolare, perché sono abituati a essere il Paese più potente al mondo e non desiderano che questo ordine globale sia messo in discussione dall’Impero di mezzo. Dall’altro lato, Pechino vuole essere una nazione sovrana, indipendente, che persegue i propri interessi, senza doversi preoccupare del giudizio di Washington. Penso che questa sia la ragione per cui i rapporti tra i due stati non stiano trovando un punto d’incontro: è la competizione in corso tra potenze in un mondo multipolare che rende pessimista la mia lettura del contesto generale».
Negli ultimi anni, se si guarda ad esempio al medio Oriente, non trova che Washington abbia fatto un passo indietro dall’essere un punto di riferimento per il mondo?
«Il Medio Oriente è una questione diversa. La dipendenza americana dalla regione era più che altro ascrivibile al petrolio. Dagli anni Settanta sino alla metà dei Duemila, il Medio Oriente è stato la questione geopolitica di sicurezza nazionale più importante per qualsiasi inquilino della Casa Bianca. Le cose sono cambiate con la rivoluzione dello scisto, che ha permesso agli Stati Uniti di essere energeticamente indipendenti. Quindi, l’allontanamento degli Usa dalla regione va contestualizzato nel quadro della sicurezza energetica raggiunta dal paese e anche dall’ammissione che gli Stati Uniti non possono essere presenti ovunque e in qualsiasi momento. La democrazia ha molte virtù, ma vi sono anche alcuni imprevisti, quali la mancanza di coerenza. È ciò che è successo con le diverse amministrazioni: durante i mandati di Obama la visione del ruolo degli Stati Uniti nel mondo e di come la politica estera doveva aiutare a mantenerlo è stata molto differente da quella di Trump, ma anche da quella di Biden. Ci sono quindi diversi cambiamenti radicali nella politica estera della Casa bianca, legati, sia alle elezioni, sia agli interessi americani. L’ironia della situazione è che ora la Cina è il più importante cliente per il Medio Oriente, in particolare per il petrolio, ed è per questo motivo che si stanno rafforzando le relazioni del paese con l’Arabia Saudita e l’Iran. Auguro buona fortuna alla Cina e di fare meglio di quanto non siano riusciti gli Stati Uniti, ma gestire i rapporti nella regione non è certo un compito facile».
Crede che ci sia un’incomprensione di fondo tra Cina e Usa?
«Difficile rispondere alla domanda, anche perché è complesso raccogliere dati a supporto di questa tesi. Penso che si debba fare una distinzione tra ciò che pensano i governi e ciò che avvertono le persone. A dire la verità, è proprio l’interazione tra queste ultime che mi preoccupa maggiormente. Se si analizzano i sondaggi fatti da agenzie quali Gallup o il Pew Research Institute, la percezione americana della Cina e dei cinesi ha iniziato a peggiorare e il Paese è visto come un problema e un avversario. Anche in Cina, dall’altro lato, la situazione non è molto diversa: gli Stati Uniti sono considerati la nazione che cerca di frenare la crescita cinese e che è ipercritica nei suoi confronti. C’è, inoltre, una mancanza di comprensione tra i governi e di volontà di capire le posizioni dell’altro».
Pensa che ci sia spazio perché questa condizione venga superata, visti anche i rapporti commerciali esistenti tra i due paesi?
«Ritengo che l’economia sia guidata dalla sicurezza nazionale. Ci sono relazioni commerciali tra Usa e Cina, alcune delle quali non cambieranno, ma l’Impero britannico e quello tedesco hanno continuato ad avere crescenti rapporti di scambio, pur consapevoli delle frizioni esistenti, sino allo scoppio della prima guerra mondiale. Proprio questo conflitto dimostra che l’interdipendenza economica tra stati non previene lo scoppio di uno scontro armato. C’è spazio perché le relazioni tra Cina e Usa migliorino? Sì, successe negli anni Sessanta e Settanta, quando l’America dovette gestire la Guerra fredda con l’Unione Sovietica e il presidente più anti-cinese di allora, Richard Nixon, decise di disconoscere Taiwan e raggiungere un accordo con la Cina, consapevole dell’impossibilità di gestire contemporaneamente due rivali nello scenario internazionale. Il riavvicinamento fra Washington e Pechino fu dettato dal mero pragmatismo. Da entrambi i lati ci potrebbero essere alcuni politici pronti a riconoscere interessi che vadano oltre quelli legati alla sicurezza nazionale e a cercare spazi di cooperazione, ma non vedo al momento alcuna personalità di questo tipo profilarsi all’orizzonte».
Ha riscontrato un significativo cambiamento dei rapporti commerciali tra Usa e Cina?
«I rapporti commerciali stanno cambiando e, da molti punti di vista, penso che si sia solo all’inizio. La Cina è ancora la più grande “fabbrica del mondo” e il primo consumatore di materie prime. Gli Stati Uniti esportano commodity, tra le quali quelle agricole, di cui l’Impero di mezzo necessita: è una dipendenza tra i due paesi che è destinata a rimanere, nonostante gli agricoltori americani siano preoccupati per il riavvicinamento tra Cina e Brasile, paese con grandi risorse di soia e mais. La situazione è invece cambiata per i settori di punta e tecnologici. Ciò successe durante l’amministrazione Trump e Huawei ne è un chiaro esempio. Gli Stati Uniti, il Paese considerato il cavaliere bianco del capitalismo, leader della democrazia liberale, decisero allora di fare terra bruciata intorno all’azienda che era all’avanguardia nel campo del 5G, perché non c’erano altre società, se non un paio nei paesi scandinavi, che potessero contrastarne l’ascesa. Oggi la situazione non solo non è cambiata, ma è aumentato il numero delle società cinesi contro le quali il governo americano ha deciso diverse restrizioni. Inoltre, è stata approvata una serie di misure, come nel settore dei semiconduttori, che hanno la finalità di contrastare l’espandersi della Cina in alcuni ambiti strategici. Negli Usa si stanno investendo trilioni di dollari nel tentativo di resuscitare la capacità manifatturiera del paese, con le aziende americane che cercano di riallocare la loro produzione fuori dalla Cina e gli effetti di questa politica si stanno allargando a macchia d’olio e impattano i rapporti commerciali».
La necessità di riorganizzare le catene di approvvigionamento è emersa con forza durante il Covid, ma non pensa che si rimanga comunque all’interno di un’economia globalizzata?
«Si sente parlare spesso di deglobalizzazione, una parola di moda, che penso venga talora usata impropriamente. Ci sono stati due stadi del processo di globalizzazione. Il primo è avvenuto durante l’Impero britannico, a metà dell’Ottocento. Il secondo, per quanto la data possa essere oggetto di discussione, è iniziato alla metà della Guerra fredda, per poi subire un’accelerazione durante gli anni Novanta ed è finito con il Covid. Ci potrà essere una terza fase nel futuro, ma, se si analizzano i numeri, il commercio globale sta iniziando a decelerare. Ora io non parlerei solo di deglobalizzazione, ma anche di riglobalizzazione. Il motivo per cui la Cina è cresciuta così tanto durante la globalizzazione è da ricercare nella sua capacità di competere contro tutti grazie a oltre un miliardo di persone e a un Partito comunista focalizzato sul raggiungimento della prosperità comune e in grado di attrarre capitale straniero. Altri paesi, come il Messico e il Brasile, non sono stati nelle condizioni di raggiungere gli stessi risultati. Non appena il commercio globale ha iniziato a scendere, la Cina ha cominciato a soffrirne, mentre ne hanno beneficiato altri stati nei quali le aziende hanno riallocato le loro attività. Perciò, anziché parlare di deglobalizzazione, magari raffigurandola come il ritorno a un periodo buio dove il commercio avviene solo all’interno di aree circoscritte, sarebbe forse meglio pensare in termini di influenze crescenti di alcuni paesi rispetto ad altri, con la creazione di sfere all’interno delle quali la globalizzazione rimane presente. Ciò che si vedrà, a tendere, sarà la competizione tra questi blocchi. La deglobalizzazione non è finita, ma si sta riconfigurando e c’è una serie di sfumature in merito a ciò che sta avvenendo che vanno colte e interpretate, soprattutto per le economie emergenti che sono state sovrastate dalla presenza cinese».
La riconfigurazione della catena di fornitura impatterà la Cina e gli Stati Uniti?
«La mia tesi è che non si sia di fronte alla creazione di due blocchi, Cina contro Stati Uniti, perché se ciò avvenisse sarebbe una riedizione della Guerra fredda. Vedo, invece, la crescita di differenti sfere d’influenza da parte di diversi paesi, quali l’India, la Turchia, il brasile, l’Indonesia, il Sud Africa e anche la stessa Unione Europea. L’India ha la potenzialità di guidare uno dei blocchi che si verranno a creare se riesce ad affrontare una serie di riforme interne. Ritengo probabile che la Turchia, con la presenza delle sue truppe in Siria e in Iraq, con il sostegno alla propria fazione nella guerra civile libica e con l’aumento dell’attività manifatturiera, a discapito dell’Europa e della Cina, eserciterà anch’essa la sua sfera d’influenza. Anche il Brasile potrà ricoprire questo ruolo ed è chiara la volontà di farlo, soprattutto quando si apre a relazioni multilaterali, e lo fa in modo pragmatico, come si è visto con la recente visita di Lula in Cina. L’Indonesia è un altro paese molto affascinante, con diversi interessi di natura geopolitica di cui non si discute a sufficienza. Il Sud Africa, non è mai all’altezza della situazione, ma ha le potenzialità di guidare uno di questi blocchi, mentre l’Unione Europea avrebbe le carte in regola per essere una zona d’influenza, se smettesse di essere un gruppo di paesi che continuano a discutere tra loro».
Come si colloca allora un potenziale scontro tra Usa e Cina all’interno di un mondo diviso in blocchi?
«Credo che i prossimi 10-15 anni segneranno un periodo eccezionale per l’economia mondiale: sarà necessario investire in innovazioni tecnologiche, riconfigurare le catene di approvvigionamento, affrontare il problema della sicurezza energetica e il cambiamento climatico. È proprio per questa ragione che traccio un parallelo con ciò che è successo nel 1890, un periodo di innovazioni tecnologiche alla fine del quale, però, ci fu un mostro in attesa: la prima guerra mondiale. Oggi non ci sono giganti nel sistema globale. La Cina è un gigante economico, ma un nano da un punto di vista militare, tanto da non essere una potenza neppure nel Mar cinese meridionale. Dalla fondazione della Repubblica popolare l’obiettivo di riconquistare Taiwan non è stato ancora raggiunto, perché non ci sono le capacità per farlo. Ciò che è preoccupante è che la Cina sta rafforzando le sue forze armate e sta investendo molto in questa direzione, ma occorreranno almeno 10 anni prima che si trovi nella posizione di entrare in conflitto con gli Usa. Non penso, quindi, a uno scontro tra le due potenze nel breve periodo, anche se si stanno preparando a questa eventualità. I prossimi anni saranno perciò impiegati a creare alleanze e partner. Da questo punto di vista, gli Stati Uniti hanno un grande vantaggio rispetto alla Cina, soprattutto se si guarda agli equilibri raggiunti nell’area Indo-Pacifico, dove la Corea del Sud, il Giappone e le Filippine sono unite da trattati di difesa. Taiwan, nonostante non sia ufficialmente riconosciuta, è nell’area di influenza americana insieme all’Australia e all’India, che rientrano nel Quad. Dall’altro lato, l’unico trattato di difesa che la Cina ha è con la Corea del Nord. Detto ciò, va sottolineato che Pechino ha mire solamente economiche e non vuole essere coinvolta in alcun conflitto».
Il parallelo con il 1890 e con quanto poi è accaduto è ipotizzabile?
«Lo è ed è ciò che più mi spaventa. Non sono preoccupato per il mondo di oggi, ma per quello in cui vivranno i miei figli. La notizia positiva, però, è che c’è tempo per cambiare la traiettoria delle relazioni, nonostante adesso non sembra che ci siano le premesse. Basterebbe che ci fosse un leader lungimirante o un mutamento importante per cambiare la rotta e dare luogo a molti altri sviluppi possibili».
C’è una proliferazione di accordi commerciali e iniziative guidate, sia dagli Usa, sia dalla Cina. Bisogna attendersi altri accordi?
«È vero, c’è la Trans Pacific Partnership (Tpp), che agli Stati Uniti non piaceva, e adesso stanno procedendo con l’Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity; poi c’è la Regional Comprehensive Economic Partnership. In aggiunta, c’è la Belt and Road Initiative, che ritengo sia, più che altro, un’iniziativa di pubbliche relazioni della Cina, che riguarda gli investimenti in infrastrutture nella regione e che ha l’obiettivo di creare maggiore integrazione tra le economie in generale. Ritengo che quest’ultima sia stata sovrastimata e che sia da considerare più uno slogan che altro, visto che il Giappone è stato molto più attivo nell’area con iniziative mirate: è anche per questo motivo che ha senso parlare di riglobalizzazione. Il Tpp è attualmente un’organizzazione che riunisce nazioni di media importanza, che vogliono instaurare al loro interno rapporti commerciali senza alcuna interferenza delle grandi potenze economiche. A tendere, credo che ci saranno più accordi di libero scambio (gli Stati Uniti, l’Unione Europea e la Russia stanno cercando di siglare un accordo di free-trade con l’India), anche se con maggiore volatilità nelle relazioni, come nel caso dell’Uruguay con il Mercosur, il mercato di libero scambio tra i paesi dell’America Latina. C’è tanta voglia di integrazione e va anche ricordato che molti di questi accordi perseguono gli interessi e i bisogni dei singoli paesi».